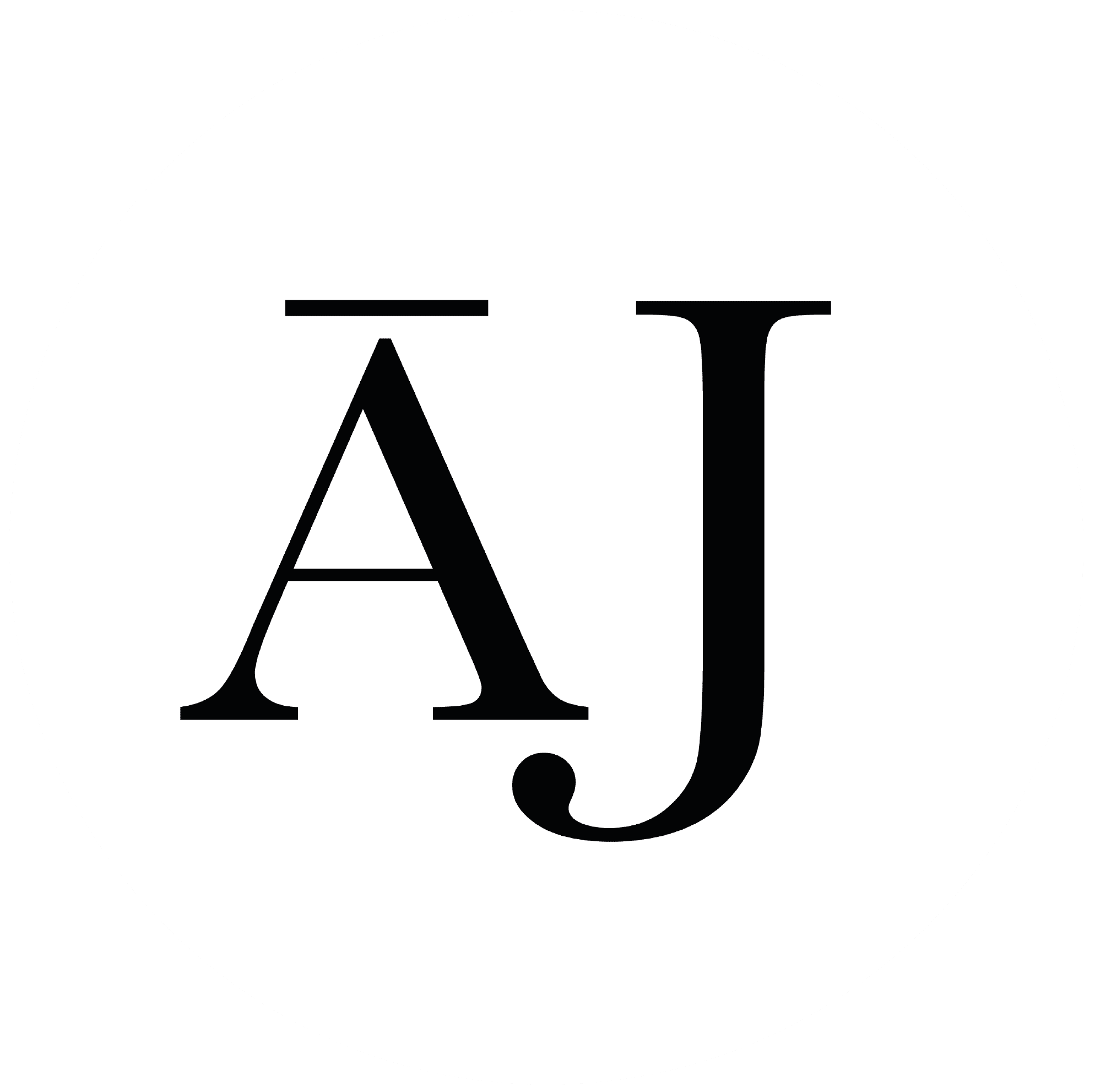Drin Drin.
“Emme! Rispondi tu.”
È tutta la mattina che mi rompe le palle. Se non le obbedisco so già come andrà a finire: è colpa tua di qui, non fai niente di là, e così via fino ad esaurimento scorte. Decido quindi di alzarmi e rimettere in moto il cervello per un po’. Metto in pausa il film su Netflix e poso il computer il più lontano possibile dalla sponda del letto.
“Pronto?” biascico. I tre passi per raggiungere il corridoio mi hanno già sfinito.
“Sabri, sei te?”
“Zia. No. Mamma è fuori che frigge. Ti faccio richiamare, ok?”
“Ok, va bene, ciao tesoro”, e attacca.
L’inutilità del mio sforzo mi fa irritare. Torno a sdraiarmi sul letto. Riprendo il mio bel computer e me lo riposiziono sulla pancia. Durante il movimento noto che sulla mano sinistra ho ancora una crosticina di quando mi bruciai un paio di settimane fa. Cerco di tirarla via con l’unghia ma tiro troppo e comincia a sanguinare. Mi infilo il dito in bocca e il sapore del sangue mi piace e vorrei che sanguinasse di più. Delusa, viro lo sguardo sul mio sterno lasciato scoperto dalla camicetta. Con la punta dell’indice della mano destra tasto alla ricerca di un brufolo. Sento un’escrescenza durognola, smetto di succhiare il dito dell’altra mano e strizzo. Qualcosa c’è ma non sembra pus. Io strizzo ancora più forte finché una minuscola goccia di liquido trasparente viene fuori e io mi do pace.
“Era Carla?” mi grida mia madre da fuori.
“Sì.”
“Che vuole ora?”
“Non lo so. Le ho detto che la richiami tu.”
Sento che bofonchia qualcosa ma non la voglio ascoltare.
“Guarda un po’ se vai su ad apparecchiare la tavola. Qui è quasi pronto”, sbotta infine, avvicinandosi sicuramente alla porta almeno la sento meglio.
Non le rispondo. Sa che le ubbidisco. Sa che devo farlo. Sa che sono costretta a farlo per non sentirmi rimbrottare più tardi fino allo sfinimento. Sa che glielo devo “per tutto quello che sta facendo per noi”.
E quindi mi alzo. Poso il computer sul letto, chiudo il monitor, mi tolgo le mutande da dentro il culo, mi metto le ciabatte ed esco di camera. Faccio il giro lungo per salire su dai miei nonni. Voglio evitare di incrociare mia madre. Non si sa mai che abbia in serbo qualche altro ordine. Secondo me le piace darmi gli ordini.
Fuori fa più caldo che dentro. Mentre salgo le scale noto una cagata di uccello secca su un gradino. Più in giù, nascosto, vedo un mozzicone volato via dal mio posacenere di cocco che tengo sempre sui gradini. Il mozzicone deve essere lì da un po’, dato che ha lasciato sotto di sé una macchiolina marroncina. Penso che forse anche i miei polmoni sono di quel colore. Mia madre me lo dice sempre che non dovrei fumare, ma a me rilassa.
Salgo le scale. Raggiungo la fine e ansimo. Guardo dritta davanti a me cercando di non guardarla neanche con la coda dell’occhio. Ma invece eccola lì, possiamo dire maestosa, senza ormai alcun pudore, sdraiata a gambe aperte sulla sua nuova poltrona ergonomica, che esibisce il suo pannolone bagnato, strinto fra cumuli di grasso che strabordano come ricotta. Sembra proprio un molosso, lì mentre sorseggia la sua bottiglietta di acqua tiepida. Non riesce più a bere come un cristiano. La mandibola inferiore sembra scollata dal viso dando mostra dell’arcata inferiore dentro il labbro sporgente. Penso che avrei sempre voluto un cane. Nemmeno si gira al rumore dei miei passi.
Nemmeno per un secondo pensa a ricoprirsi le gambe, o almeno il pube fasciato come quello di un bebè. Chi è questo alieno?
“Nonna? Come stai?”
A malapena si gira a guardarmi. Gli occhi fissi sulla faccia del Papa che dice la messa con una voce buffa e incomprensibile. Lei la messa l’ha sempre guardata in TV ogni domenica da quando ha smesso di andare in chiesa. Ormai saranno cinque anni, credo. Le passo davanti e vado in cucina. Apro una credenza e prendo la tovaglia. L’odore di carne arrostita è arrivato fino a qui nonostante sia tutto sbarrato, neanche fosse inverno. Stendo la tovaglia grossolanamente e mi accorgo che finalmente gira la testa verso di me. Non sorride ma mi guarda fissa con gli occhi di una che si è appena fatta un’enorme riga di coca.
“Nonna?”, ripeto facendole un sorriso timoroso.
“Eh…” Il suono che le esce dalla bocca è a metà fra il lamento di piacere di un vecchio che vede i suoi cari e il mugolio di un pazzo a cui è stato tolto il telecomando.
“Hai fame?” le chiedo non sapendo che altro chiederle.
Nessuno sa ormai parlare altro che di cibo in questa casa. È l’argomento franco che è rimasto ad accomunarci tutti. Mia madre cucina i contorni, mio nonno cucina la brace, mia zia prepara la caprese quando viene a trovarla o porta del cibo extra per lei in graziose bacinelle colorate, e io mi limito a mangiare. A tavola parliamo del cibo che stiamo mangiando, del cibo che cucineremo domani, di quello che potrebbe andare alla bocca cattiva di mia nonna.
“No.…” guaisce tornando con la faccia al televisore.
“Come no? Non hai mangiato stamani.”
Ci mette qualche secondo.
“Nonna?”
“No, eh.”
“Dai che oggi ci sono le alette di pollo alla brace con le patatine! Ti ci vanno le patatine? Sono buone. Quelle nuove. Nonno le ha raccolte stamani.”
Non mi risponde. Continuo ad apparecchiare la tavola. Prendo tre bicchieri e tre piatti piani dalla credenza e me li metto impilati sul braccio sinistro per risparmiare un viaggio. Torno in sala e mentre li sistemo sento il rumore plasticoso della traversa posizionata sotto il suo culo per non macchiare di pipì la poltrona nuova. Alzo lo sguardo e la vedo agitarsi. Prova a tirarsi su aggrappandosi goffamente con entrambe le mani alle spalliere.
“Nonna! Aspetta ti aiuto io”, le dico pensando che voglia cercare una posizione più comoda.
Ma invece alza una chiappa e scorreggia con la finezza di un camionista. Poi ne tira un’altra e un’altra ancora. Non avevo mai sentito mia nonna tirare una scorreggia fino ad ora. Faccio finta di niente. Lei non mi guarda imbarazzata, né mi chiede scusa. Faccio finta di non rendermi conto neanche di questo.
Ma non voglio nemmeno dimenticare. Non la devo dimenticare. La ricordo mentre stende i panni e canta. Cantava bene, come Anna Magnani. I pacchetti di sigarette che comprava e mi nascondeva nel cassetto, era il nostro piccolo segreto che tutti sapevano. Il suo bisogno di venire a vedere cosa stessi facendo ogni giorno, anche quando non ero più piccola. Le bustine di soldi che mi dava senza bisogno di una ricorrenza. Il suo sorriso perfetto, più bello che nelle foto di quando aveva vent’anni perché più dolce, più da nonna. La ricordo mentre mi portava in bici lungo il viale alberato per andare a trovare mio nonno quando ancora lavorava. A sgranare i piselli le sere d’estate. La merendina il pomeriggio. Le giornate a vedere Mary Poppins. Io seduta in braccio a lei appoggiata alle sue enormi e morbide tettone da nonna.
E poi mi viene in mente quello che dice mio nonno. Anzi, diceva, prima che fosse bandito qualsiasi discorso cupo: “Bimba, se rimango un vegetale, mi raccomando: sacchetto in testa e vai a comprarti le sigarette”, poi annuiva come a rispondersi di sì da solo. Avrei voluto rispondergli di sì anche io, ma non ce l’ho mai fatta. Rispondere di sì significava accettare che un giorno sarebbe morto, sarebbero morti tutti quelli seduti accanto a me, prima di me, e poi sarei morta anche io.
Mi dimentico di finire di apparecchiare. Lei è sempre immobile sulla sua poltrona a prendere aria tra le cosce. Vorrei mettermi a sedere accanto a lei ma io veramente il Papa e i suoi discorsi da Papa non li sopporto. Lo vorrei vedere, lì che fa ancora quei discorsi con una nonna messa male come la mia. Probabilmente non ce l’ha mai avuta una nonna, il Papa.
Quindi vado giù, mi mancano solo dieci minuti per finire il film. Poi si mangerà, si deciderà cosa mangiare stasera, si prenderà il caffè e poi potrò tornare a digerire e a non pensare bella sola nella mia stanza.
Mi sdraio sul letto, riprendo il computer e sento il rimbombo dal muro di un passo lento, vecchio e stanco che sale le scale. È mio nonno che torna sconfitto da sua moglie con la brace in mano. Sa già che lei ne mangerà appena, e quello che mangerà andrà sommerso di maionese se vogliamo che non scioperi del tutto la fame. Ad entrambi ci viene il disgusto.
“Elsa”, la guarda accennando una smorfia simile ad un sorriso. “Hai fame?”
Lei si gira verso di lui, muovendo macchinosamente solo il collo e la testa ma tenendo il resto del corpo completamente immobile, le spalle schiacciate contro la poltrona ergonomica beige. Non risponde ma lo trafigge con lo sguardo, come a dirgli: “Perché non mi rompi? Così grossa non c’entro in un bidone, rompimi del tutto, se mi ami”.
Lui per un secondo ci pensa, a romperla. Poi fissa per terra, il pavimento è sempre lì, solido, ma gli regge comunque le gambe. Posa il ciotolone con la carne alla brace sulla tavola, si siede a capotavola come sempre e ci aspetta. So che è lì che fissa il televisore spento. Non lo accendiamo neanche più, se no si rischia di non sentire nonna che si lamenta. Lo schermo nero sembra dirgli qualcosa di brutto, appoggia i gomiti pesanti sul tavolo e si prende la testa tra le mani. Tra le dita gli si intravedono gli occhi aperti, fissi e appannati su quella televisione che gli dice cose sempre più brutte.
Si assopisce per qualche secondo nella sua disperazione, finché un altro rumore di passi, questa volta magro e ritmato, si acuisce dalla tromba delle scale. Mia madre sta salendo con un’enorme teglia di patate fritte che ostinatamente d’estate e d’inverno cuoce fuori, sotto la tettoia, per non impuzzare la casa di fritto. Anche la carne vuole che si cuocia fuori perché è diventata vegetariana e ora l’odore di ciccia morta le fa venire la nausea. Io mi rifiuto comunque di cuocere fuori. Un’altra enorme perdita di tempo. Il puzzo in casa va via, prima o poi. Il tempo perso nessuno te lo ridà.
Appena prima che sbuchi il suo viso, mio nonno si ricompone; si strofina gli occhi, guarda la tavola mezza apparecchiata, si alza spingendosi con le mani sul tavolo, guarda mia nonna e va in cucina.
So che non contano su di me neanche per apparecchiare e che lui lo sta per finire al posto mio. Non contano su di me per niente, alla fine. Questa cosa mi spezza, mi spezza tutto, dalle gambe alle braccia. Non riesco ad aiutarli in nessun modo, non riesco a farlo bene. Se apparecchio, mi dimentico qualcosa. Se pulisco, lascio le macchie perché doso male il detersivo per pavimenti. Mia mamma infatti dice che ne metto troppo, ma io sono dell’idea che più ne metti, più viene pulito. E nessuno me lo toglie dalla testa.
Ma soprattutto, non riesco ad aiutarli con mia nonna. Non riesco a darle da mangiare perché vederla così, che si sbrodola come una enorme bambola deformata, mi fa venire da piangere. Non riesco ad alzarla perché è troppo pesante. E lavarla, lasciamo perdere. Era lei che lavava me. Non posso sopportare di doverle togliere la merda dal pannolone. Anche se lei ora non lo sa e non lo può dire, so che non vorrebbe che lo facessi. Preferirebbe morire. Lo so. E non vorrebbe neanche che lo facessero mio nonno, mia mamma o la zia. Ma qualcuno deve farlo e di solito sono sempre i grandi che fanno le cose difficili. Ma come si diventa grandi se non facendo cose difficili? Io non riesco a far nulla, di difficile. Sono una smidollata. Qui sdraiata col mio film a non diventare grande.
“Le diamo da mangiare?” dice mia mamma appena atterrata in sala da pranzo. “Mh”, borbotta lui.
“Mamma, ce la vuoi la maionese sulle patate?”
Silenzio.
“Sì, eh.”
“Bene! Due minuti e si mangia.”
Mia mamma sgambetta in cucina e si mette ad armeggiare con qualcosa. Mio nonno nel mentre ha una bottiglia d’acqua in una mano e una di vino nell’altra. Vorrei andare su ad aiutarlo ma sono bloccata nel letto come se il computer sulla mia pancia pesasse un quintale.
“Sabrina!” urla d’un tratto.
Mia mamma ha una scossa improvvisa. In un nanosecondo si volta a destra e a sinistra come se si aspettasse l’agguato di un leone. Scatta in salotto. Mio nonno, curvo su mia nonna, le sta reggendo le spalle mentre lei ha la testa mezza ribaltata all’indietro, gli occhi pure ribaltati e la bocca che le trema. Sembra la Pietà di Michelangelo. L’ho studiata a scuola.
Mia mamma rimane bloccata a fissare la scena da un metro di distanza, le braccia a mezz’aria e la bocca semiaperta come se stesse giocando a un due tre stella. Cerca di pensare a qualcosa, vuole una soluzione. Ma tutto d’un tratto non ce n’è più bisogno. Gli occhi di mia nonna ruotano in avanti, la bocca si raddrizza e sembra aver trovato di nuovo la capacità di muovere il collo. Fissa mio nonno mentre un filo di bava le sborda da un lato della bocca. Mi ricorda quel ragazzino handicappato che era con me alle medie. Poverino. Mi è sempre dispiaciuto provare pena per lui. Mia madre è sempre lì che guarda sua madre handicappata e non si muove. Solo impercettibilmente, e se uno le fosse proprio vicino vicino potrebbe notare che le sue dita stanno tremando come una zanzara che frigge.
“Elsa…” geme mio nonno mentre la fissa, invecchiato di altri dieci anni in qualche secondo. Lei gli fissa la mano che è ancora stretta intorno alla sua spalla e tenta di alzare la sua.
“Hai sete?” le chiede e senza aspettare risposta si allunga e afferra la bottiglietta di prima con la cannuccia rossa che spunta. Gliela avvicina alla bocca e lei stringe la cannuccia tra i denti e succhia piano piano, con il labbro penzoloni, facendo uscire dell’acqua dai lati della bocca.
Mia madre, intanto, si è rinsavita e sta armeggiando col cellulare. Preme un tasto e si mette il telefono all’orecchio mentre cammina impaziente tra il salotto e la cucina voltandosi ogni tre secondi verso mia nonna.
“Il dottore non risponde!”
“Che si fa?” chiede lui con con la voce strozzata.
“Non ne ho idea.”
“Chiamiamo l’ambulanza?”
Mia mamma non risponde ma pensa che non ce la farebbe a rifare le notti all’ospedale e si sente in colpa.
Qualcosa vibra.
“Aspetta, mi sta richiamando”, e corre sul terrazzo dove prende meglio. “Salve dottore”, e poi non si capisce più nulla.
Mio nonno la fissa da dentro come un cane a cui è stato comandato di star fermo. La fissa anche se non la vede più. Poi ad un certo punto lei risbuca. Sta ammiccando al telefono.
“Mh”, borbotta con la bocca stretta e le sopracciglia arricciate. “Ma dice che è normale così?”
Mio nonno nel mentre guarda mia nonna che invece guarda nel vuoto. Forse si aspetta che lei lo consoli dicendogli che è normale così, che dopo una caduta dalle scale e la mancanza di ossigeno al cervello queste crisi sono normali, che un’ischemia può causare in seguito ripetute alterazioni cardiache che portano perdite di coscienza momentanee.
Mia nonna però non dice nessuna di queste cose. Lo fa mia madre al suo posto non appena mette giù, finendo con l’inutile rassicurazione che il dottore la verrà a visitare o oggi o domani mattina presto.
Perché in fondo si sa tutti come andrà a finire. Lei smetterà del tutto di obbedire al fisioterapista, smetterà anche di mangiare, poi avrà un’altra ischemia, una bella forte, riandrà all’ospedale in ambulanza mentre noi tre in ciabatte nel mezzo della notte staremo a guardare imbambolati come falene le luci che si allontanano dal vialetto. E all’ospedale la nutriranno con un sondino, le sue energie evaporeranno completamente, verrà intubata, e alla fine i reni collasseranno e di mia nonna resterà solo un contenitore vuoto, privo di qualsiasi essenza.
E questo contenitore poi si riempirà di acqua e scorie come uno scatolone di carta sotto un temporale. E verrà messo in una bara e chiuso con i chiodi. E verrà murato in alto, accanto ai miei bisnonni, non per terra perché lei non voleva prender acqua da morta. E tutto questo durerà un mese infinito. E non si potrà evitare.
Ma forse è l’ora che io salga su. Tra poco vedrai che si mangia. Prima però bisogna dare da mangiare a lei. Non casca il mondo se aspetto qualche secondo in più.
Infatti mio nonno si sta sedendo proprio adesso davanti alla sua poltrona su un puff messo lì apposta. Guarda il piatto fondo pieno di alette accuratamente disossate e di patatine ricoperte di maionese che tiene in mano, e pensa che sembra la ciotola di un cane. Si rende anche conto che gli è passata la fame. Alza lo sguardo verso di lei e si accorge che manca qualcosa. Si alza di nuovo, poggia il piatto sul puff e va in cucina. Prende un bavaglio da un cassetto e torna ciabattando verso la sua postazione. Le lega il bavaglio intorno al collo e riprende il piatto in mano. Deve essere proprio difficile ritrovarsi a imboccare tua moglie.
“Emme dov’è?” chiede mia madre guardandosi intorno.
“Dove vuoi che sia”, risponde lui mentre allunga il cucchiaio gelatinoso verso la serratura dentata di mia nonna.
Mia mamma è arrabbiata, lo so. Lo sento. Forse non tanto con me, ma sono l’unica con cui si può arrabbiare. Forse le do anche io volontariamente tutte le ragioni per farlo.
“Emme!” urla lei all’improvviso dalla tromba delle scale.
Via. È l’ora. È l’ora di andare in scena. La solita scena da settimane con le solite banali battute. Ho il voltastomaco. Scatto sul dal letto con un’energia che non pensavo di avere…
“Ma dov’eri?”
“Eh, scusa. Mi ero appisolata.” Mento spudoratamente ma so che anche se avessi detto la verità non avrei sorpreso nessuno. Rimango un attimo in piedi davanti al tavolo.
“Manca niente?” dico mentre mi siedo.
“La tua acqua. Prenditela.”
Non bevo l’idrolitina come loro, è salata quell’acqua. Stanno tutti a lamentarsi dell’acqua del mare quando la bevono e poi a casa riempiono le bottiglie di idrolitina. Non mi alzo, bevo dopo. Prendo invece un paio di alette di pollo e me le metto nel piatto. Mi allungo poi verso il vassoio di patatine. Ci starebbero bene due salse. A questo pensiero la testa mi si alza involontariamente verso mia nonna. La sua ciotola è quasi vuota e un po’ della maionese che fino a poco fa era nel piatto penzola ora ai lati della sua bocca.
Penso che alla fine posso evitarle, le salse. Prendo invece una manciata di sale e me lo spruzzo sulle patate in abbondanza. Mia mamma sala pochissimo, nulla direi. Dice che il sale fa venire il colesterolo. Secondo lei tutte le cose buone fanno male. Sarà allora che invece le cose cattive fanno bene?
“Ne vuoi di più?” le chiede lui.
“No, eh”, sospira lei.
“Ha mangiato tutto?” domanda mia madre che si sta mettendo a sedere con in mano il suo piatto di ciccina finta di seitan, come la chiama lei.
Ecco, lì sopra la maionese sarebbe d’obbligo per coprire quel saporaccio plasticoso. Una volta è riuscita anche a farmela assaggiare: “È uguale al pollo”, mi disse. Ma non ci casco più. Io non so cosa abbia lei al posto delle papille gustative ma quello è tutto fuorché pollo.
Mio nonno si alza. Mia nonna ha di nuovo gli occhi puntati verso la TV. Il Papa finalmente ha finito e ora è in onda Linea Verde. Dalla sua espressione ebete ho i miei dubbi che riesca a recepire quello che dicono. Forse le donne che un tempo venivano mandate negli ospedali psichiatrici dai mariti avevano proprio la stessa espressione dopo l’elettroshock. Anche questo l’ho imparato a scuola.
A vederla così uno non ci crederebbe che prima aveva la memoria di un delfino. Riusciva a fare un cruciverba, tutto un cruciverba in un battibaleno. Era un dizionario di nonna. Sapeva il nome di tutti quelli che vedeva in TV, giornalisti, presentatori o presentatrici, gli omini del meteo, anche se li aveva visti o sentiti una volta sola. Credo che li sapesse tutti tranne due: uno che chiamava sempre Giacchetton perché mentre presentava il TG indossava sempre una giacca enorme con le maniche strabordanti; e una che chiamava Dentona, e il motivo si capisce da soli. Mia nonna odiava quelli coi dentoni. Sono sicura che fosse il suo unico peccato. Chissà perché. Forse qualche bambino coi dentoni l’aveva bullizzata da piccina. Lei non ce l’ha mai detto e io non credo di averglielo mai chiesto.
Ed ora eccola lì, esempio lampante della legge del contrappasso. Una mezza ebete smascellata che non riesce a nutrirsi o a farsi nutrire decentemente a causa dei denti di fuori.
Un fazzoletto le accarezza dolcemente la bocca. Le bavette sono sparite.
“Oh, issa.”
Mio nonno si è tirato su dal puff. Arranca in cucina, il cucchiaio schiocca nel piatto posato nel lavabo. Poi risbuca e si siede.
“Bimba, passami un po’ di vino”, mi chiede.
Glielo passo. Finalmente siamo tutti e tre seduti al tavolo. Inizia il conto alla rovescia. Di solito si mangia in dieci minuti al massimo. Do un’occhiata ad entrambi; lei sta sminuzzando i già piccoli pezzettini di seitan, lui tituba davanti alla ciotola con le alette come se dovesse scegliere da un menù poco appetitoso, io do inizio alle danze prendendo un’aletta con le mani e la azzanno.
“Come sono venute?” domanda lui. “Buonissime, nonno.”
“Non sono troppo piccanti?”
“No no. A me piacciono.”
“Bene, allora ne mangio una anch’io, via.”
Ne prende una piccola e se la mette nel piatto. Anche lui allunga la mano verso la saliera e ci spruzza abbonante sale. Secondo me non sono sciocche quelle, ma lui fa sempre così. Anche in un piatto di sale ci metterebbe il sale sopra. Mia mamma lo guarda e storce la bocca. Lui afferra la mini-aletta con le sue manone da contadino e ci tira un morsotto.
“Mh, dai. Non son venute cattive.”
“Ma sì eh”, rispondo io a bocca piena.
“Papà, non le vuoi due patatine?” chiede mia mamma allungandogli il vassoio.
“Sì, via, ma due di numero”, e con la solita manona ne afferra una manciata e se la butta nel piatto. Il pranzo finisce in fretta. Io che mi strafogo, mia mamma che mangia come un canarino il suo pasto magro e stentato e mio nonno che al posto dell’apparato digerente ha un tubo diretto al culo e in dieci minuti è l’ora del caffè. Mi sento così in colpa per non aver fatto niente, e sinceramente ho anche tanta voglia di tornare al mio film, che decido di rendermi utile.
“Lo preparo io il caffè”, dico mentre mi alzo.
Mia mamma si sveglia dal suo torpore: “Sì, però non ci mettere poca acqua, che te lo fai troppo forte il caffè”.
“Ok”, rispondo pensando che mi è già passata la voglia.
Apro il mobiletto dove si trova la moka, accendo il rubinetto e da brava bambina la riempio fino al bullone, non di meno, per carità, sennò quella là chi la sente dopo.
“Nonno, lo vuoi corretto?” dico a voce alta mentre riempio accuratamente il filtro di caffè.
“No, oggi no”, risponde lui.
È da quando è cambiata mia nonna che il caffè non lo prende più corretto. Se mi chiedessero di esprimere un desiderio adesso, qualunque desiderio, vorrei che mio nonno ricominciasse a mettere il liquore nel caffè.
Accendo il fuoco, ma schioppetta e non parte. Tiro un moccolo mentale e prendo l’accendino al lato dei fornelli. La moka finalmente è sul fuoco. Ora sparecchio, bevo il caffè, scuoto la tovaglia, fumo una sigaretta e faccio un pisolino davanti al computer e tutto il resto sparisce.
Torno in cucina e prendo per prima cosa i piatti che mi impilo di nuovo sul solito braccio, li appoggio nel lavello e uno ad uno ci tolgo i rimasugli di cibo con un po’ di Scottex perché mi fa schifo, e li getto nell’umido.
Sento una sedia stridere, mia mamma mi si avvicina da dietro. Non si fida di come metto i piatti nella lavastoviglie.
“Vieni, faccio io”, mi dice infatti, e il suo è più un ordine che una gentilezza.
Controllo allora il caffè che sta iniziando a fumare. Alzo il coperchio e quello sta cominciando ad uscire bello denso dalla pipetta. Prendo allora le tazzine dalla credenza, ne allineo tre davanti a me, mi allungo a prendere lo zucchero e le riempio tutte e tre; la mia con un bel cucchiaio, quella di mio nonno con due cucchiai pieni e quella di mia madre con una puntina perché lo zucchero fa male.
“A nonna lo faccio il caffè?” le chiedo per smorzare il tempo.
Lei ha una ghigna che le tocca il pavimento, ha gli occhi fissi sui piatti che praticamente sta già lavando con spugna e sapone e penso che sia inutile metterli nella lavastoviglie, ma non le dico nulla.
“Mamma?”
“Eh?” risponde lei che solo adesso mi ha sentito.
“Dicevo, a nonna lo faccio il caffè?”
“Prova a sentire se lo vuole.”
Speravo non mi dicesse così. Chiudo gli occhi e inspiro. Mi volto e vado verso mia nonna con lo sguardo al pavimento. Le arrivo davanti, noto i piedoni gonfi con centinaia di capillari rampicanti che da quanto sono lividi sembrano quasi bolliti.
“Nonna?”
Alzo lo sguardo. Lei mi guarda come si guarda un fantasma.
Deglutisco: “Lo vuoi il caffè?”
Ad un certo punto lei mi sorride, le piaceva il caffè.
“Sì, eh”, risponde quasi decisa, rimettendosi subito a guardare la TV. Le sorrido come si fa ad un cane molto vecchio quando ti passa accanto. Mi affretto in cucina e aggiungo una tazzina. “Mettiglielo in una tazza grande che in quella non riesce a berlo”, erompe mia madre che ha appena finito di riempire la lavastoviglie con le stoviglie pulite.
Prendo allora una tazza da latte e ci aggiungo un cucchiaio e mezzo di zucchero. Spengo il fuoco e verso il caffè: stracolmo per mio nonno, quasi pieno per me, due dita per mia mamma e il rimanente per mia nonna che probabilmente non sa nemmeno di averlo voluto.
“Glielo dai tu a nonna?” mendico io.
“Sì. Glielo do io.”
Guarda la fila di tazzine. Poi prende quella giusta e mi gira le spalle. Io prendo le altre e le porto di là.
Mi siedo accanto a mio nonno e lo guardo mentre soffia sul suo caffè con un’espressione buffa che se non sapessi che lui non è tipo da smorfie, penserei che lo stia facendo solo per farmi ridere. Ne beve un sorso, fa la boccuccia, si succhia le guance e mi guarda.
“T’è venuto buono.”
“Grazie”, rispondo contentissima neanche mi avesse dato la bustina di soldi delle feste. Sorrido e prendo la mia tazzina quasi ansiosa di assaggiarlo io stessa il mio buon caffè.
Mia madre si alza dal puff. Torna a sedere a tavola. Si siede come una signorina e inizia a girare lo zucchero col cucchiaino guardando la finestra dritta davanti a sé. La guardo e penso che se fosse diversa sarebbe tutto più facile. Lo sguardo mi cade sul tavolo e vedo la tazzona di mia nonna con tutto il caffè dentro. Mia madre avvicina la sua tazzina alla bocca che si arrotonda a culetto mostrando tutte le sue rughe da cinquantenne poco curata. Io la continuo a fissare involontariamente e ogni suo gesto sembra a rallentatore. La sua bocca si digrigna in una smorfia di disgusto.
“Ma l’hai fatto amarissimo”, dice praticamente gettando la tazzina sul tavolo. “È imbevibile. Lo devo fare io il caffè, via”, e si alza prendendo di nuovo la tazzina e portandosela via.
A passo svelto va in cucina e ci scommetto che sta versando il caffè nel lavello neanche fosse il pannolone puzzolente di nonna. Io giro lo sguardo a mio nonno che puntualmente evita il mio.
“È così, che si deve fare”, bofonchia lui senza che lei lo senta.
Mi irrigidisco, non si può vivere così. Non ci si può mettere anche lei a crocifiggere tutti dall’alto della sua perfezione. Nonna non l’avrebbe mai fatto. È sempre stata così antipatica ma da quando nonna è in questo stato è diventata anche peggio, insopportabile. Non ce la faccio più a sentirmi trattare come una mongoloide. E che cazzo, non ne faccio una giusta. Ma quel giorno, che mi ha fatto a fare?
Eccola che risbuca dalla cucina. Prende il suo piatto e quello di mio nonno e mentre riparte mi dice: “Via ma che fai, devo fare tutto io anche oggi?”
La fisso colma di rabbia. Scatto in piedi e prendo le bottiglie e una vorrei tirargliela in testa. Ci ritroviamo in cucina una di schiena all’altra.
Non riesco a stare zitta: “Comunque datti una calmata”.
“Cosa? Datti una calmata? Faccio tutto io in questa casa.”
“Sì oh, e nonno non fa nulla, giusto?”
“Ma che vuol dire? Lui è in pensione. Ci vai tu a lavorare otto ore al posto mio?”
“Tranquilla che appena finita la scuola mi trovo subito un lavoro.”
“Sì, ti ci voglio vedere, sfaticata come sei come ti prendono a lavorare.”
“Ah già, sei brava solo te, dimenticavo.”
“Ti sembra di essere brava a far qualcosa tu?”
“A scuola vado bene.”
“Oh, hai la media del sette, a casa mia è sopra il sufficiente.”
“Ma che cazzo dici? Il sette è distinto a casa mia.”
“Hai praticamente da fare solo quello.”
“Perché scusa te quanto avevi quando andavi a scuola?”
“Io non chiedevo tutto quello che chiedi tu.”
“E cosa chiedo io? Vado avanti coi soldi che mi dà papà.”
“Sì, i soldi del mantenimento che dovrei tenere io ma che ti prendi tutti tu.”
“E tieniteli allora! Basta che la smetti di rompere le palle.”
“Io i soldi di tuo padre non li voglio.”
“E allora non rompere le palle.”
“La farete finita una volta per tutte voi due”, tuona mio nonno, faccia nelle mani, e la sua voce cavernicola improvvisamente ci placa. Entrambe bambine col broncio, poco cresciute.
“Via io vado giù, non ti sopporto più.”
“Brava torna a letto.”
Corro inculita verso le scale e vedo mio nonno piegato sul tavolo con la testa tra le mani. Mi vergogno, e mi vergogno di mia madre perché so che lei non si vergogna.
Apro la porta della mia stanza. Faccio per prendere una sigaretta sul mobiletto ma il pacchetto è vuoto. Diamine. Mi butto sul letto. Che colpa ne ho io se sul letto ci sto così bene. E anche se fossi nata incapace, non sono stata io a farmi, sarà anche colpa loro.
La porta è rimasta aperta, allungo una gamba e con una spinta riesco a chiuderla sbattendola. Sono talmente nervosa che non mi va nemmeno di guardare il film. Vorrei poter sentire cosa starà dicendo adesso mia madre a mio nonno. Sicuramente che “sono una figliola ingrata”, che “sono uguale a mio padre”, che “sarei dovuta andare a stare da lui” e così via, mentre quel pover’uomo pensa che sarebbe meglio che ci togliessimo dalle palle tutte e due e forse il sacchetto in testa se lo vorrebbe metter lui da sé per smetterla di sentirci che ci scanniamo così mentre mia nonna marcisce in silenzio.
Vengo interrotta da un rumore di passi. È mia madre che è scesa e ora è entrata in camera sua per cambiarsi. Poi rumore di grucce, silenzio, altri passi svelti verso il bagno, rubinetto aperto, spazzolino, sputo, spazzola, interruttore, altri passi verso la cucina, porta d’ingresso che sbatte.
E finalmente, silenzio. Se n’è andata e per quattro ore posso stare in pace. Da sopra la mia testa sento altri passi, questo è mio nonno che si va a riposare un’oretta. Mia nonna dopo pranzo dorme sempre, non più con mio nonno ma sulla sua poltrona. Lui le abbassa lo schienale col telecomandino e lei si arena lì e chiude gli occhi buona come il pane. Questo è l’unico momento di riposo di mio nonno. Non è vero che non fa nulla, lui sta con lei tutta la notte a controllarla perché è di notte che lei fa le bizze. Saranno coliche o avrà paura del buio, non lo so. Però sento sempre un gran trambusto da sopra e dormo male pure io. Mamma non ne parla mai, non so se lei lo sente ma io sì. E la mattina andare a scuola ed essere da otto è dura.
Penso che neanche mi ricordo più come si stava prima di stare così, si stava meglio però. Tranne quando io e mamma litigavamo e nonna allora piangeva e nonno si incazzava con noi. È sempre stata troppo sensibile. Un po’ sono anche io così, ma non come lei. Spero solo che adesso non capisca cosa le succede intorno e non stia male per la sbuferata di oggi.
La dovrei smettere di rispondere a mia madre comunque. Sarebbe segno di maturità. Almeno cambierei le cose in qualche modo. O forse dovrei mettermelo io il sacchetto in testa visto che non sono capace di far nulla e sono solo un peso. Ma dopo sono convinta che lei ci starebbe di merda se non ci fossi più.
O forse dovrebbe metterselo lei, così io e mio nonno staremmo tranquilli e in pace. Ci sarebbero però tutte le pulizie da fare, che io non ho voglia. Si potrebbero usare i soldi di papà per pagare una donna che venga a stirare e spolverare. Ma chissà quanto prende una donna per pulire? E dove si trova.
Alla fine, forse è a mia nonna che andrebbe messo un sacco in testa. Almeno smetterebbe di soffrire, mio nonno prima o poi se ne farebbe una ragione perché lui è sempre stato più forte di lei e sicuramente soffrirebbe meno se lei sparisse piuttosto che a vederla svanire così. E mamma si darebbe una calmata e la smetterebbe di essere così tanto odiosa, ed io allora sarei più tranquilla, dormirei meglio, sarei meno stanca e potrei aiutare di più in casa e prendere otto a scuola.
Ma per fare una cosa del genere ci vuole coraggio, come papà e mamma quando fecero sopprimere Bob che aveva il cancro e non mangiava più. Papà mi raccontò che quando morì era fra le sue braccia e la sua testa ad un certo punto barcollò all’indietro ed era morto. Nonna avrebbe anche l’appoggio della poltrona quindi la sua testa rimarrebbe ammodo, al massimo penderebbe da un lato.
“Bimba, se rimango un vegetale, mi raccomando: sacchetto in testa e vai a comprarti le sigarette”, mi risuona nella testa.
Ma avrei il coraggio? Quanto ci metterà uno a morire con un sacchetto in testa? Forse una siringa sarebbe meglio ma io ho sempre avuto paura delle punture. Di sacchetti in casa ne abbiamo a bizzeffe, nonno tiene quelli per la spazzatura in un cassetto. Poi le andrebbe fissato al collo però, lo scotch credo sia in un cassetto sotto il televisore, ci avevo attaccato una foto in camera qualche giorno fa. E magari dopo tutto cambia e io divento matura e tutti siamo molto più felici e nonna crede in Dio, quindi, andrà in paradiso e sarà anche lei più contenta e in pace.
Il soffitto è bianchissimo. Mi alzo. Apro delicatamente la porta, vado in salotto e apro il cassetto sotto il televisore. Mi ricordavo bene. Prendo lo scotch. Apro la porta. Salgo le scale e sono leggera. Guardo mia nonna che dorme sulla sua poltrona. Arrivo in cucina e apro il cassetto dei sacchetti, ne prendo uno. Torno in salotto e mi fermo davanti a lei che si è svegliata e ha gli occhi aperti dritti verso di me. Mi guarda che mi avvicino con il sacchetto di plastica e lo scotch in mano. Mi avvicino piano, come un gatto malfidato. Ma il suo sguardo sembra accogliente, benevolo. Mi chino davanti a lei e lei non smette di guardarmi. Sto piangendo in silenzio. Le appoggio una mano su una guancia rugosa, la faccio scivolare giù sulla spalla e poi la sposto dietro la scapola, dolcemente. Le salto poi addosso e la abbraccio e mi scappa un singhiozzo ma non devo farmi sentire quindi soffoco la faccia nell’incavo della sua clavicola e respiro il suo odore, lo assorbo come ossigeno. Lo memorizzo, ne analizzo il DNA per non dimenticarlo, anche se so che lo dimenticherò. Questo pensiero mi fa singhiozzare di nuovo, ma devo essere forte, devo essere grande. Mi allontano dal suo corpo e la guardo. Le prendo una mano e lei, inaspettatamente, me la stringe, me la stringe fortissimo. In questo momento voglio credere che esista un paradiso per lei da qualche parte.
“Ci vediamo presto, va bene?”
Lei mi guarda.
“Sì, eh”, risponde e so che la smorfia che si forma sul suo viso è un bellissimo sorriso. Il più bello che mi abbia mai fatto.
Mi alzo, le gambe mi tremano, le mani mi tremano e non riesco a separare i due strati del sacchetto di plastica. Il rumore di una russata di mio nonno mi fa sussultare. Ma è ora il momento giusto, ora che dorme pesantemente. Apro il sacchetto finalmente. Guardo per un’ultima volta il sorriso di mia nonna e le inserisco la testa nel sacchetto. Lei è docile come un cane a cui stai per togliere una zecca. A volte far male è per il bene. E i cani lo sanno, e mia nonna lo sa. Sbuccio lo scotch ma mi scivola nelle mani sudate. Me le asciugo sulla maglietta mentre tengo lo scotch fermo tra i denti. Dal sacchetto si intravedono a malapena le forme del suo viso. Sta respirando già affannosamente ed il sacchetto si gonfia e si sgonfia mostrando l’incavo della sua bocca. Ma lei non si muove. Lo vuole davvero. Sbuccio lo scotch e ne allungo una bella striscia. Le gambe mi ballettano. Lei mi sta aspettando. Mi scaglio su di lei e velocemente le blocco il sacchetto intorno al collo con due giri di scotch.
Lo lascio attaccato lì, al suo collo, e corro giù. Scendo le scale due scalini alla volta. Sono al piano terra, ora che la morte è alle mie spalle sento che posso rallentare. Una persona matura non scappa. Una persona grande fa quello che è giusto, sacchetto in testa e ti vai a comprare le sigarette. Io il sacchetto gliel’ho messo.
Vado in camera mia e prendo 5 euro e venti dal portafoglio e la tessera sanitaria. Non prendo il portafoglio perché l’ultima volta mi è caduto dai pantaloncini mentre andavo a comprare le sigarette e l’ho perso e mia mamma mi ha fatto una testa così. Mi siedo sul mio letto. Il computer è ancora lì. Chissà come va a finire il film che stavo guardando? Mi infilo le Vans, ne lego prima una, poi l’altra. Prendo telefono, auricolari ed esco di casa.
Ora sono in strada e passeggio piano. Scorro la playlist ma non riesco a trovare neanche una canzone adatta a questo mio nuovo essere grande
SOSTIENI ĀTMAN JOURNAL
Sostenere Ātman Journal vuol dire entrare a far parte di una comunità che crede, come noi, che internet possa mantenere le sue promesse originali: promuovere nella società il dibattito creativo, libero e indipendente e democratizzare la cultura. Di fronte alla prepotenza dei giganti digitali, la sua stessa presenza è un gesto di resistenza e di sfida.
IBAN
IT54 U030 6909 6061 0000 0400 546
PAYPAL